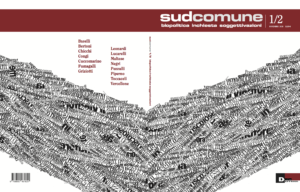di CARLO VERCELLONE (in sudcomune, n.0/2015)
l’utopia statalista del nuovo meridionalismo (I)
Alla fine della seconda guerra mondiale, il «blocco gramsciano» degli operai e dei contadini aprirà un nuovo e ultimo ciclo di lotte segnato dalla congiunzione di due dinamiche principali: al Nord, la partecipazione di massa della classe operaia alla «resistenza» si somma alla tradizione autogestionaria del movimento dei Consigli; a Sud, la caduta del fascismo si accompagna a una indiscutibile «rinascita» del movimento contadino e della società civile, che determina la crisi della mafia agraria e che condurrà a una trasformazione strutturale di tutti i termini tradizionali della «questione meridionale». La sua espressione più significativa sarà il movimento di occupazione delle terre che si prolungherà fino alla fine degli anni Quaranta, favorito dal decreto Gullo del 1944/45. Questo movimento costituirà l’epicentro di un’azione collettiva e di forme cooperative di autogoverno della produzione e di accesso alle terre, che ricordano da vicino la logica del comune; prima di deviare, sotto l’egida del governo di solidarietà nazionale, verso una prospettiva centrata sulla piccola e media proprietà e sulla logica clientelare che presiederà la legge di riforma agraria del 1950 .
I soggetti sociali della «mancata svolta del dopoguerra», incapaci di costituire un modello di società alternativa, alimenteranno una complessa dinamica “conflitto – innovazione – sviluppo”, e costituiranno il più potente incentivo del riformismo del capitale. Questo si tradurrà in un progetto di trasformazione radicale del regime di accumulazione e del rapporto Nord/Sud, fondato sul rapporto stretto tra lo Stato e il capitale, tra il Pubblico e il privato, secondo una prospettiva di cui ricostruiremo i tratti salienti dal punto di vista della grande industria privata, espressa da Valletta, e dell’utopia statalista del nuovo meridionalismo, formulata da Pasquale Saraceno. Si tratta di una pagina storica di grande attualità: tanto per le controversie che continua ad alimentare sulle cause della persistenza della «questione meridionale», quanto per gli insegnamenti che ci lascia per comprendere le condizioni sulle quali costruire oggi l’orizzonte d’emancipazione di un Sud fondato sul comune.
1. Il dibattito sulle condizioni della crescita fordista e la riorganizzazione dei rapporti Nord/Sud nell’immediato dopoguerra
Nel dopoguerra, l’Italia si trova di fronte a due scelte cruciali per l’adozione di un nuovo modello di sviluppo: la prima riguarda il rapporto che lo Stato e l’economia italiana dovevano stabilire con l’eredità del modello autarchico e di economia controllata lasciato in eredità dal fascismo; la seconda riguarda il ruolo che doveva essere assegnato all’economia meridionale e pertanto le riforme strutturali necessarie a garantire la realizzazione di una nuova articolazione del rapporto Nord/Sud.
Il dibattito che si sviluppa intorno a tali questioni tra il 1945 e il 1950 vede confrontarsi tre approcci principali.
Nel primo periodo (1945/47), quello dei governi di solidarietà nazionale, due principali correnti di pensiero hanno dominato il dibattito politico, a detrimento di una riflessione d’ispirazione keynesiana che conquisterà una posizione egemonica a partire dalla fine dell’esperienza dei governi di coalizione. La prima corrente si ispirava a una posizione liberista e trovava la sua espressione teorica più articolata presso gli economisti della scuola einaudiana dominante in ambito universitario (Einaudi [1980], Demaria [1979], Corbino [1979]). Secondo questo approccio, i paesi dovevano optare per un modello il più vicino possibile all’idealtipo di un’economia del laissez-faire e del libero scambio. Questa opzione implicava lo smantellamento delle barriere protezioniste e delle istituzioni del modello di economia controllata (compresa la privatizzazione delle imprese controllate dall’Istituto per la Ricostruzione Industriale, d’ora in avanti I.R.I.) voluto dal regime fascista dopo la grande crisi degli anni ’30. Un’altra conclusione logica di questo paradigma teorico fu che la soluzione della «questione meridionale» doveva essere lasciata al libero gioco delle forze di mercato. Questa teoria, detta «dei tempi lunghi» (Einaudi [1980]), riportava, in sostanza, il Mezzogiorno alla sua tradizionale specializzazione centrata sull’agricoltura. Eppure, va notato che Luigi Einaudi, come governatore della Banca centrale, darà prova di grande pragmatismo per ciò che concerne tanto la politica monetaria quanto gli altri aspetti della politica economica. E finirà anche con l’appoggiare il progetto per la costruzione della Cassa per il Mezzogiorno, sostenendo di non essere contrario a una politica dei grandi lavori infrastrutturali che avrebbero creato un ambiente favorevole allo sviluppo dell’iniziativa privata.
La seconda corrente, derivante dall’economia politica del marxismo sovietico, fu l’espressione delle posizioni degli economisti del Partito Comunista Italiano. Questi ultimi, tesi a riaffermare da un punto di vista teorico la superiorità del modello sovietico di economia collettivista, sostenevano che l’Italia non era matura per una vera e propria pianificazione. Consideravano, come Pesenti [1972], il più brillante economista del P.C.I. dell’epoca, che la pianificazione era non solo impossibile, ma anche non desiderabile in un sistema in cui la proprietà privata dei mezzi di produzione non era stata soppressa. Avrebbe, infatti, piuttosto funzionato come strumento di asservimento dello Stato e dell’economia ai grandi monopoli privati: «La planification capitaliste ne peut non seulement pas atteindre les objectifs affichés avec autant de démagogie mais elle ne peut pas non plus stabiliser le système» (Pesenti citato da Barucci [1978], p. 238).
Un corollario importante di questo approccio, in termini di “capitalismo monopolistico di Stato”, era l’opposizione a una politica di industrializzazione del Mezzogiorno operato «de l’extérieur ou du sommet (de l’Etat) et qui, sous la couverture d’une action technique» (Amendola, citato da Barucci [1978], p.341) non avrebbe fatto altro «qu’ouvrir la route à l’expansion des grands monopoles privés, y compris étrangers» (ibidem). Queste interpretazioni spiegano, in larga misura, la scelta del P.C.I. di votare contro la legge che nel 1950 istituirà la Cassa per il Mezzogiorno.
Malgrado i presupposti politici molto differenti, si produsse una convergenza “paradossale” tra le posizioni marxiste del P.C.I e quelle liberali, che andavano dalla questione del rapporto tra Stato e mercato al rifiuto di una politica di industrializzazione per il Mezzogiorno (Castronovo [1980]). Come ricorda Barucci, durante il periodo dei governi di solidarietà nazionale, questo “incontro di estremi” era stato così perfetto che tutti quelli che proponevano una terza via «apparaissaient comme des nains en train de soulever les colonnes d’un temple» (Barucci [1978], p. 237).
Bisogna comunque notare che il richiamo ai principi del liberalismo economico di cui si servivano i datori di lavoro e la D.C. nell’immediato dopoguerra aveva più un valore tattico e congiunturale che quello di una vera e propria adesione ideologica. In una situazione ancora segnata da un forte dualismo di potere nelle fabbriche come nelle campagne, come dalla partecipazione della sinistra al governo, il paradigma liberista offriva un discorso teorico già sperimentato per legittimare l’offensiva contro tutte le forme di controllo operaio e gli ostacoli alla libertà d’impresa. In realtà, i datori di lavoro e la Democrazia Cristiana (D.C.) non desideravano né il ritorno a una mitica economia del laissez-faire né lo smantellamento del settore pubblico e delle istituzioni di controllo dell’economia lasciate in eredità dal fascismo. Per il “capitale collettivo” e soprattutto per la parte più dinamica della grande industria settentrionale, questa eredità rappresentava un’acquisizione irreversibile che non andava rimossa ma adattata nel quadro della transizione da una regolazione autarchica e corporativa verso una regolazione fordista-keynesiana che richiedeva una ridefinizione globale del rapporto Centro/Periferia.
Un terzo approccio, che conquista progressivamente una posizione egemone, sosteneva una prospettiva riformista d’ispirazione keynesiana associata a un approccio sviluppista relativo alla necessità di industrializzazione del Mezzogiorno. Questa corrente, che raccoglie grandi manager di Stato (anche dell’I.R.I.) e una nuova generazione di economisti modernizzatori, spesso vicini alla D.C., troverà un cruciale momento di organizzazione teorica e istituzionale nella creazione dello SVIMEZ (acronimo di Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno). L’associazione, fondata nel 1946 dal ministro socialista dell’industria Morandi, era anche il più importante luogo di incontro di due riformismi: quello del partito socialista italiano, incarnato nell’approccio alla programmazione di Morandi e quello sviluppista-keynesiano di Saraceno. La SVIMEZ sarà il principale centro di elaborazione di questa politica di industrializzazione del Mezzogiorno che rappresenterà, almeno teoricamente, la filosofia ufficiale dell’intervento della Cassa per il Mezzogiorno. Tale partito trasversale giocherà un fondamentale ruolo ispiratore del dibattito sulla politica economica in Italia e sul piano Vanoni del 1953, relativo alla realizzazione del progetto di programmazione e istituzionalizzazione di un esplicito compromesso fordista, che sarà alla base, all’inizio degli anni ’60, della costituzione di coalizioni di centro-sinistra e del ritorno del partito socialista al governo. Questa corrente afferma, un po alla volta, l’egemonia di una “terza via” (Barucci [1978]) che rilancia insieme le tesi liberali e quelle del P.C.I. sull’impossibilità di una politica di pianificazione dell’economia di mercato. L’intervento dello Stato non solo era legittimo e necessario, ma doveva puntare soprattutto all’industrializzazione del Mezzogiorno poiché era escluso che un cambiamento in agricoltura, quale che fosse la portata della riforma agraria, avrebbe potuto fornire una soluzione alla “questione meridionale” (Saraceno [1977]).
È così che a partire dal 1947/48, una volta ristabilito il controllo padronale sulle fabbriche – ed eliminata l’ipoteca che la presenza della sinistra al governo avrebbe fatto pesare sul ruolo dello Stato – il dibattito sulle scelte di politica economica si “libera” della sua cristallizzazione ideologica. In questa nuova congiuntura, le posizioni difese dalla corrente sviluppista-keynesiana si concretizzano, almeno in parte, in una serie di riforme e nella realizzazione delle principali istituzioni destinate ad assicurare la concretizzazione e regolazione del fordismo: il “programma di ricostruzione dell’economia italiana”, inscritto nel quadro del piano Marshal (1947), il consolidamento delle strutture istituzionali dell’industria pubblica legate all’I.R.I. (1948) e la creazione nel 1953 dell’E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi), la stabilizzazione della lira e l’adesione al sistema di scambio fissato da Bretton Woods (1947-1949), l’espansione del sistema di protezione sociale e della legislazione sul lavoro e, soprattutto, le leggi di riforma agraria e quelle per la creazione della Cassa per il Mezzogiorno (1949-1950).
Sicuramente, questa riorganizzazione del rapporto tra “Stato e mercato”, tra settore pubblico e capitale privato, non avrà come obiettivo prioritario una politica di reale differenziazione dei meccanismi della crescita del Nord a discapito del Sud, cosa che avrebbe implicato, per esempio, una pianificazione “vincolante” per le grandi imprese private settentrionali. La problematica di una politica di uscita del Mezzogiorno da una condizione di “sottosviluppo” è dunque formulata e ricercata con sincerità dai vertici dello Stato, ma dentro la logica della crescita fordista e delle contraddizioni imposte da tale modello di sviluppo. A tal proposito, la prospettiva di una immediata politica di riequilibrio Nord/Sud è in particolare limitata da una scelta che, tanto per i manager della grande industria quanto per i grandi commissari dell’I.R.I. e della Cassa per il Mezzogiorno, sembrava inevitabile: l’imperativo dell’apertura del sistema economico, legato alla necessità di inserire l’Italia nella nuova configurazione mondiale dell’accumulazione, che si afferma sotto l’egemonia degli Stati Uniti. Questa scelta implica di dare la priorità alla politica di modernizzazione della struttura industriale già esistente; e rende inevitabile, almeno nel medio termine, la prosecuzione di uno sviluppo ineguale (Graziani [1979]). Questa priorità degli obiettivi, tuttavia, non esclude la realizzazione dello Stato-piano e di un programma di ridefinizione radicale del rapporto Nord/Sud. Punta alla stretta integrazione del Mezzogiorno nella crescita fordista, tanto dal punto di vista del mercato del lavoro e dell’interruzione dei circuiti della domanda quanto come spazio di espansione della capacità di produzione industriale.
Nelle prossime pagine ci si propone di mostrare come la “filosofia” che ispirerà le politiche di regolazione della crescita fordista e di pianificazione del territorio si forma a partire dalla sintesi, in un piano coerente, di due punti di vista: quello della grande industria settentrionale e dei settori di Confindustria maggiormente interessati alla modernizzazione, espressi dall’amministratore delegato di FIAT Valletta; quello dei “nuovi meridionalisti”, espressi da Saraceno, grande manager dell’industria pubblica dell’I.R.I. e teorico dello SVIMEZ. L’approccio di Saraceno incarna, al livello più elevato, ciò che possiamo chiamare “l’utopia statalista del nuovo meridionalismo”, e avrà un’influenza determinante nella filosofia e per la creazione della Cassa per il Mezzogiorno.
- Il punto di vista di Valletta: la riserva di manodopera e il mercato protetto del Mezzogiorno come motore dello sviluppo fordista
Nel dibattito sulle grandi scelte di sviluppo, che si tenne presso la “Commissione economica dell’assemblea costituente” della prima Repubblica, Valletta, amministratore delegato della FIAT, definisce, a partire dal 1946, lo scenario di una dinamica di crescita che mette in evidenza il nuovo ruolo strategico attribuito al Mezzogiorno dalla grande industria settentrionale. Nella sua relazione al parlamento, dopo aver richiamato i problemi congiunturali legati alla ricostruzione, Valletta affronta il tema delle prospettive strategiche per l’economia italiana. Suo punto di partenza è l’esigenza di una politica di liberalizzazione del commercio estero, in rottura con la regolazione autarchica instaurata dal regime fascista dopo la crisi degli anni Trenta. Una politica di apertura dell’economia era infatti richiesta con forza dai settori più avanzati della grande industria, per affrontare le strozzature relative tanto alla struttura della domanda quanto a quelle dell’offerta interna. Dalla parte della domanda, il carattere ancora limitato del mercato interno non poteva garantire, nel dopoguerra, le opportunità sufficienti per avviare la produzione di massa. Questo perché, la crescita delle esportazione sembrava, almeno nel medio termine, una condizione indispensabile per la realizzazione delle economia di scala e la redditività degli enormi investimenti richiesti dalla modernizzazione fordista. Dalla parte dell’offerta, tutta la storia dell’economia italiana era stata caratterizzata dalle strozzature legate a una penuria di materie prime. Più che altrove, lo sviluppo industriale aveva sempre comportato la possibilità di finanziare uno sviluppo parallelo delle importazioni. Adesso, nel dopoguerra, tale peso strutturale del vincolo esterno era accentuato dalla necessità di importare le apparecchiature che incorporavano le nuove norme di produzione che la produzione di beni nazionale non era in grado di fornire.
Anche il ruolo delle esportazioni è da subito concepito da Valletta come un mezzo complementare e non antagonista all’espansione del mercato interno. Questa attitudine è testimoniata dal giudizio critico e dall’assenza di ogni nostalgia di Valletta per il modello di regolazione concorrenziale precedente alla svolta autarchica del fascismo.
«Che cosa facevamo noi all’epoca in cui non eravamo ancora in regime autarchico?… Dovevamo conquistare mercati stranieri e ci trovavamo nella condizione di dover fare una piccolissima produzione, la quale non è sufficiente per avere dei bassi prezzi. Ciò era conseguenza della mentalità italiana secondo cui il prodotto di serie è naturalmente un prodotto di secondo ordine, mentre la produzione non di serie è un prodotto magnifico».
Tale situazione, continua Valletta, ci costringe a produrre modelli diversi in serie molto piccole:
«perchè un tipo di carrozzeria possa essere immediatamente economico ci vogliono almeno ventimila esemplari di quel tipo di carrozzeria. Per tutte queste ragioni ci trovavamo nella condizione che le proporzioni di quantità delle macchine da costruire, se avessero dovute essere fatte per la sola Italia, sarebbero state non solo antieconomiche ma addirittura impossibili. Allora cosa convenne di fare? Siccome avevamo la fortuna che gli iniziatori della Fiat, Agnelli e Fornaca, avevano puntato il loro lavoro soprattutto sulla riduzione dei prezzi all’estero, noi abbiamo seguito la stessa politica. Se si completa con le vendite all’estero la scarsa produzione dell’interno, ci si pone in condizione di produrre un tipo a costo decente» (ibidem, pag. 129)
In breve, il modo di regolazione autarchica e corporativista-repressivo del fascismo aveva irreggimentato la grande industria nel “circolo vizioso” delle piccole serie, di una produzione debole e di rendimenti decrescenti che avevano reso impossibile l’avvio della produzione di massa.
Valletta, se ne comprendono bene le ragioni nella sua relazione al Parlamento, non fa menzione della soluzione che il fascismo aveva proposto per questa impasse: la realizzazione tra il 1936 (anno dell’aggressione militare contro l’Etiopia) e il 1945 di una “economia di guerra”. L’espansione delle commesse pubbliche legate all’armamento sembra infatti, in questo periodo, più che compensato dalla stagnazione di altre componente della domanda e giustifica la realizzazione da parte di FIAT di un progetto monumentale per il nuovo stabilimento di Mirafiori, inaugurato nel 1939.
Comunque sia, con la fine del regime fascista diviene ormai possibile e necessario mettere in campo un modello keynesiano di allargamento (pacifico) del mercato. In questa prospettiva, l’espansione del potere d’acquisto delle classi popolari e l’integrazione nel mercato europeo, rappresentavano i due motori di una stessa dinamica auto-sostenuta dalla produzione e dal consumo di massa. Questo cambiamento – afferma in sostanza Valletta – permetterà la transizione da una logica di produzione fondata sulla piccola serie di prodotti fortemente differenziati alla produzione in gran numero di pochi veicoli di piccola cilindrata. E renderà possibile una crescita parallela della produzione e dell’occupazione articolate verso il conseguimento di forti guadagni di produttività e verso la realizzazione di importanti economie di scala. In effetti,
«Naturalmente oggi in che condizione ci troviamo? Che a mercato aperto e senza le conseguenze dell’autarchia, abbiamo la quantità per i tipi piccoli “500” e “1100”». In più se ci accordiamo con gli americani per fare qualche cosa, evidentemente possiamo arrivare un giorno al punto che, moltiplicandosi la capacità di assorbimento automobilistico in Italia e all’estero, si potranno aggiornare i nostri tipi addirittura sugli standard americani» (ibidem, pag. 130).
Bisogna notare che l’ottimismo di cui da prova Valletta relativamente all’opportunità per l’Italia di importare il modello americano, contrasta nettamente con lo scetticismo di molti economisti e uomini politici dell’epoca (Graziani [1979]). Questi pensavano che il ritardo della struttura industriale, e la vocazione agraria del Mezzogiorno sottosviluppato, rappresentassero degli ostacoli praticamente insormontabili allo sviluppo della produzione e del consumo di massa. Il valore dell’argomentazione di Valletta sta esattamente nel rovesciare questa tesi. Mostra come alcune principali manifestazioni di tale “ritardo”, quali la sovrabbondanza di manodopera e il carattere praticamente vergine del mercato del Mezzogiorno, potevano al contrario rivelarsi come formidabili elementi di vivacità per lo sviluppo del fordismo. Infatti,
«Per due ragioni chi ha una certa pratica in materia ritiene sicura la vira dell’industria meccanica e dei motori in Italia: prima per ragioni di efficacia tecnica e di mano d’opera, poi per ragioni d’indole commerciale» (ibidem, pag. 127).
Seguiamo il modo in cui Valletta argomenta questi due motivi.
Dal punto di vista “tecnico e della composizione della mano d’opera”. È infatti molto significativo che Valletta, nel sostenere il primo motivo, associa i due fattori rappresentati dall’organizzazione del lavoro e dalla composizione della forza lavoro. Intende così mostrare che in Italia è possibile stabilire la sinergia tra l’adozione del modello americano di organizzazione del lavoro e la struttura del mercato del lavoro. In altri termini – dice in sostanza Valletta – l’introduzione dei protocolli tayloristi e fordisti della produzione di massa implica un consumo massiccio di forza lavoro “dequalificata”. La sovrabbondanza strutturale di forza lavoro, generata dal sottosviluppo del Mezzogiorno, avrebbe potuto giocare per la ristrutturazione dell’industria settentrionale, un ruolo comparabile a quello svolto per lo sviluppo del taylorismo negli Stati Uniti dalle ondate d’immigrazione transoceanica. O meglio, nel contesto europeo, l’offerta illimitata di forza lavoro proveniente dall’agricoltura meridionale divenne la fonte di un vantaggio considerevole per la competitività del fordismo italiano.
«L’avvenire dell’azienda è però buono e la FIAT, in qualunque regime economico, liberista o vincolista moderato, può riuscire benissimo, perché in Italia l’industria meccanica in generale e quella automobilista in particolare, se pure hanno deficienza di materie prime, possono contare su un mercato basso della manodopera più che altrove e per decenni: se un miglioramento delle condizioni di vita si verificherà, questo sarà generale e la differenza tra noi e gli altripermarrà. Ciò naturalmente sempreché, poursuit Valletta en faisant clairement référence au rôle de l’Etat, si sappiano sviluppare le cose con criterio e organizzazione» (ibidem).
Bisogna precisare che nell’approccio di Valletta l’importanza attribuita a ciò che la teoria economica, con Lewis (1954), battezzerà come offerta illimitata di forza lavoro, congiuntamente ad altri meccanismi istituzionali di formazione dei salari, non corrisponde affatto a un’idea pre-keynesiana del salario, inteso come costo in un regime di crescita espansiva. Se l’offerta illimitata di forza lavoro del Mezzogiorno dovrebbe garantire all’Italia un vantaggio competitivo rispetto ad altri paesi europei, il ruolo del salario è immediatamente inteso in termini fordisti come un elemento chiave della domanda. Tale complementarietà appare con maggior chiarezza quando Valletta argomenta il secondo motivo alla base della sua fiducia nell’avvenire dell’industria meccanica, essenzialmente legato alle potenzialità di espansione del mercato interno.
Dal punto di vista “commerciale”. Un’altra componente centrale della strategia industriale di Valletta consiste nel mettere l’accento su una specializzazione accentata da segmenti produttivi. Così, l’avvio della produzione di grandi serie si sarebbe dovuta inizialmente concentrare su automobili di piccola cilindrata dove la competizione era meno forte e l’espansione della domanda, soprattutto in Italia, prometteva di essere più rapida. Infatti, proprio in ragione del suo ritardo, il mercato italiano offriva eccezionali prospettive di sviluppo. In Italia, alla fine del periodo della ricostruzione, non c’erano che una macchina per 94 abitanti, mentre lo stesso rapporto in Inghilterra era di 1 a 20, in Francia di 1 a 25, in Belgio di 1 a 27, in Svizzera di 1 a 28:
«il nostro è un paese che dovrà raddoppiare e triplicare la sua produzione. Noi siamo in Europa fra i più arretrati: la circolazione è ancora ridicola in rapporto alle nostre possibilità» (ibidem, pag.129).
La rimonta di questo ritardo in termini di infrastrutture e di diffusione delle norme del consumo di massa «occorre fare un lavoro particolare e ritengo che saremo in grado di farlo». In questo contesto, il Mezzogiorno era per Valletta non solo una riserva inesauribile di mano d’opera per l’industria del Nord, ma anche la riserva di una potenziale domanda, anch’essa inesauribile, che doveva essere continuamente alimentata dall’intervento dello Stato. Tale idea è a più riprese esplicitata da Valletta. Così, nel suo discorso al consiglio di amministrazione della FIAT nel 1952, precisa chiaramente le condizioni macroeconomiche dell’interruzione del circuito produzione-consumo di massa:
«L’incremento della produttività presuppone pure un incremento di mercato perché sviluppando la produzione (e i moderni mezzi tecnici sono capaci di darle sviluppi vertiginosi) i mercati normali sono presto saturati e occorre crearne dei nuovi, suscitare continuamente sempre nuovi e più vasti strati di consumatori. Dove? Dal profondo delle masse popolari e dalle popolazioni di regioni e continenti arretrati. Come? Aumentando il potere d’acquisto di quelle masse, di quelle popolazioni, così che i consumi si estendano»
Dall’approccio di Valletta sulle prospettive di sviluppo del fordismo in Italia emerge chiaramente la necessità di un intervento dello Stato nel Mezzogiorno articolato intorno a due assi principali: una politica dei “grandi lavori pubblici” che, pur sostenendo i redditi della popolazione, fosse in grado di costruire una rete di infrastrutture (soprattutto stradali) necessarie allo sviluppo della motorizzazione di massa e alla modernizzazione dell’economia meridionale; una politica di “trasferimento di reddito e creazione dell’occupazione” nel settore pubblico per integrare in tempi relativamente brevi il Mezzogiorno nel circuito del consumo di massa, anche in assenza di un processo di industrializzazione che potesse creare una struttura produttiva e occupazionale simile a quella delle regioni settentrionali.
Insomma, mentre il fordismo svela il salario non solamente come costo ma anche come domanda, una politica di sostegno al reddito del Mezzogiorno si presentava come elemento essenziale dello sviluppo progressivo delle norme del consumo fordista. Questa politica keynesiana della domanda sarebbe stata, insieme alla crescita dei salari nell’industria settentrionale, la leva principale dell’interruzione del circuito macroeconomico fordista. Va notato infine, dentro questa logica, lo stretto legame che esiste tra le due dimensioni. Le “masse popolari” del Mezzogiorno sono così identificate tanto come soggetto centrale delle politiche di sostegno keynesiano al potere d’acquisto quanto, attraverso le migrazioni interne Sud-Nord, come nucleo principale per la costituzione del rapporto salariale fordista nelle grandi imprese del Nord Ovest.
Invece, la strategia industriale proposta nel dopoguerra dalla FIAT di Valletta e, in modo più generale, da tutti i principali gruppi privati, difficilmente considera, nel medio termine, il Mezzogiorno come spazio di “localizzazione”. Ciononostante, l’approccio di Valletta corrisponde a un sostegno implicito a una politica di “preindustrializzazione” che, più che permettere la diffusione degli standard di consumo, potesse costituire le “precondizioni” che, nel lungo termine, avrebbero reso ugualmente redditizia la sua integrazione come zona d’industrializzazione periferica.
Insomma, se il fordismo imponeva la scelta di una crescita diseguale e concentrata al Nord, dove si trovava il motore del regime di accumulazione, quella scelta non escludeva una politica di intervento che, in maniera subordinata al meccanismo principale, tendeva a funzionalizzare il dualismo, ad attenuarne le conseguenze economiche e sociali più gravi, e a conseguire ugualmente, in questo contesto, un’azione di parziale perequazione (Ferrari Bravo – Serafini [1972]).
TRADUZIONE DAL FRANCESE DI ANNA CURCIO
NOTE
Barucci, P., [1978], Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno, éd. IL Mulino, Bologne.
Castronovo, V., [1980], L’industria italiana dall’ottocento a oggi, éd. A. Mondadori, Milan.
Corbino, [1979], «No al cambio della moneta», pp. 163-166, in (a cura di) Graziani, L’economia italiana dal 1945 ad oggi, éd. Il Mulino, Bologne.
Demaria, G., [1979], «Difesa del libero mercato», pp. 137-139, in (a cura di) Graziani, A., L’economia italiana dal 1945 ad oggi, éd. Il Mulino, Bologne.
Einaudi, L., [1980], «Il Mezzogiorno ed il tempo lungo», pp. 217-220, in (a cura di) Fissore, G., Meinardi, P., La Questione meridionale, éd. Loescher, Turin
Ferrari Bravo, L., & Serafini, A., [1972], Stato e Sottosviluppo : Il caso del Mezzogiorno italiano, éd. Feltrinelli, Milan.
Lewis, A..W. ([1954]), «Economic Development with Unlimited Supllies of Labour», pp. 139-191, in The Manchester School of Economic and Social Studies, Mai.
Pesenti, A., [1972], Manuale di economia politica, 2 Vol., éd. Riuniti, Rome.
Revelli, M., [1989], Lavorare in Fiat : da Valleta ad Agnelli a Romiti Operai Sindicati Robot, éd. Garzanti, Milano.
Saraceno, P. [1977], Intervista sulla ricostruzione, éd. Laterza, Roma-Bari.
Valletta, V., [1979], «L’industria automobilistica : un avvenire sicuro. (Rapporto della commissione Economica 1946)» in, A. Graziani (a cura di), L’economia italiana : 1945 – 1970, Il Mulino, Bologna 1972.(a cura di)