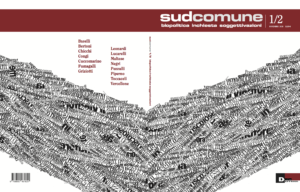in «sudcomune. biopolitica inchiesta soggettivazioni», n. 1-2/2016
L’intervista a Federico Bertoni, in occasione della pubblicazione del suo importante lavoro Universitaly. la cultura in scatola, è stata condotta nell’ambito dell’inchiesta sugli studenti e le trasformazioni dell’Università che l’Associazione sudcomune e il Laboratorio di Sociologia dell’educazione e delle culture dell’Università di Roma 3 hanno iniziato nel corso del 2016, e della quale sono stati presentati gli obiettivi sul portale del collettivo Effimera (06/04/2016). Universitaly è un libro che coglie nel segno, che descrive chiaramente “dall’interno” i principali elementi della crisi universitaria ed offre le categorie adeguate alla sua comprensione, nonché diversi spunti critici per il suo superamento.
SUDCOMUNE: La lettura di Universitaly è importante per diversi motivi, tra cui il fatto che le trasformazioni indotte dalle recenti riforme universitarie sono lette dall’interno, da un prof. che ama il suo lavoro e vorrebbe “mettere in comune” il suo sapere. In «Cominciò tutto così», uno dei primi paragrafi del libro, si legge che quando hai cominciato a insegnare, ai primi anni del 2000, «il ’68 era ormai lontano come il giurassico. Stava iniziando l’era dell’eccellenza». Più in avanti nel testo, a proposito del corpo docente scrivi: «Siamo in piena mutazione: ci stiamo trasformando a tutti gli effetti in amministratori, ingranaggi della macchina ed esecutori solerti di ingiunzioni burocratiche, azioni che compiamo in gran parte attraverso i dispositivi informatici (…) Non vogliamo capire che l’evoluzione del sistema universitario ha cambiato la natura stessa delle responsabilità: il nostro compito primario non è più contribuire al progresso della conoscenza e condividerla con gli studenti, ma reagire puntualmente alle ingiunzioni ed eseguire i comandi in modo rapido, completo e preciso». Come e perché è avvenuto tutto ciò? Ci racconti i tratti salienti di questa nuova era dell’eccellenza consolidatasi dalla Riforma del 3 + 2 a quella berlusconiana della Gelmini?
FB. Il come è presto detto: una rapida e capillare espansione della macchina burocratica, il cui funzionamento è stato in gran parte demandato ai docenti e in prima istanza a coloro che hanno assunto incarichi amministrativi o di governo, dai rettori ai presidi di facoltà, dai direttori di dipartimento ai presidenti di corso di laurea. Già l’applicazione della riforma Berlinguer ha comportato una complicatissima ingegneria didattica per mettere a punto gli ordinamenti dei corsi di laurea, con un sistema che di per se stesso mette in primo piano i conteggi, i rapporti numerici, le procedure e il funzionamento del sistema a scapito dei contenuti, che infatti hanno visto una inesorabile deriva verso il basso, o comunque verso l’irrilevanza. Negli anni successivi, vari provvedimenti legislativi – culminati con la Legge 240 del 2010 (la cosiddetta Legge Gelmini) – hanno sviluppato e “perfezionato” questo processo, con un livello di efficacia e di interiorizzazione del dispositivo davvero impressionante. Ormai l’università non è più un luogo di produzione e di condivisione della conoscenza, ma una macchina cibernetica fine a se stessa che deve fissare determinati obiettivi, misurare il rendimento, stabilire parametri di valutazione, dimostrare a qualcuno (ispettori, revisori, contribuenti…) che gli obiettivi sono stati raggiunti con “efficienza” ed “efficacia”.
Al di là delle considerazioni politiche, il motivo profondo mi ha indotto a scrivere il libro è una sorta di condizione esistenziale: un senso di tradimento dell’idea di cultura in cui ho creduto, per la quale ho studiato e insegnato a tanti studenti; e la sensazione molto concreta di perdere il significato stesso del mio lavoro, di fronte all’evidenza che le attività sostanziali a cui mi dedico (studiare, progettare i corsi, preparare bene le lezioni, seguire con attenzione gli studenti nella preparazione della tesi, ecc.) sono del tutto irrilevanti per il funzionamento della macchina, guidata e alimentata da altri criteri. La “qualità” di cui tanto si parla è solo la quality assurance, un sistema astratto di obiettivi, parametri e strumenti di valutazione che incidono solo a livello procedurale. Mi è sembrata perfettamente sintomatica, da questo punto di vista, una dichiarazione di Luciano Modica del dicembre del 2006, quando il Ministero guidato da Fabio Mussi (in cui Modica era sottosegretario) annunciava trionfalmente l’istituzione dell’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca, ormai il vero centro del potere politico-accademico. Tutta l’enfasi era appunto sulla “qualità”, ma declinata solo in termini formali, economici e cibernetici, nella totale indifferenza per la qualità intesa come insieme di proprietà sostanziali che rendono una cosa quella che è: «Valutare il sistema significa valutare la qualità, parola chiave per tutto il sistema. Qualità è parola è polisemantica: esistono diversi significati e tante accezioni d’uso, tutti importanti. […] Qualità intesa come fitness for pourpose, in relazione all’idoneità degli scopi da raggiungere. Qualità come conformità, in relazione alla soddisfazione dei clienti (customer care). Qualità come rispetto degli aspetti formali. Qualità come eccellenza, intesa in relazione al merito. Qualità come bene formale, da rendere riconoscibile e trasparente (accountability). Qualità come informazione (empowerment). Qualità come conoscenza del sistema». Insomma, la prassi quotidiana dell’insegnamento conferma a qualunque docente del XXI secolo che il contesto in cui ci muoviamo è questo, che siamo parte di una grande corporation burocratica in cui non importano le cose che facciamo ma solo le procedure che eseguiamo, in cui gli studenti non sono persone che reclamano il diritto al sapere ma clienti da soddisfare, consumatori di beni e servizi, acquirenti di un prodotto che dovranno vendere a loro volta nel mercato globale.
Più difficile dare una risposta plausibile sul “perché”. Al di là degli interessi contingenti o degli obiettivi dichiarati (ridurre i costi, uniformare il sistema italiano a quello internazionale, rendere l’università più efficiente e competitiva, ridurre il divario tra formazione e lavoro, ecc.), credo che in gioco ci siano alcune trasformazioni strutturali delle società occidentali nel quadro delle economie neoliberali. Non a caso, i processi che da qualche anno stanno investendo l’Italia si sono sviluppati già da vari decenni in altri Paesi, soprattutto quelli anglosassoni, dove peraltro non mancano voci fortemente critiche sui guasti prodotti da queste misure di “riforma”. Con la smaterializzazione e la delocalizzazione dei processi produttivi, l’evoluzione tardo capitalista delle economie occidentali ha investito infatti su una “società della conoscenza” in cui sono stati ricollocati i sistemi educativi, regolati sempre più da forme di governo e meccanismi di gestione importati dal mondo dell’impresa privata, in un quadro generale che coinvolge anche altre sfere del servizio pubblico, dalla giustizia alla sanità. Il mercato è diventato un principio regolativo universale, e in questo senso l’università è solo una piccola porzione, a mio avviso particolarmente rappresentativa, di un fenomeno molto più ampio. In Europa, anche qui non a caso, tutto è iniziato nell’Inghilterra thatcheriana a metà degli anni Ottanta, con una serie di direttrici che si stanno sviluppando puntualmente anche da noi: riduzione del finanziamento pubblico, crescita della contribuzione studentesca, calo dei fondi statali per il diritto allo studio e offerta di prestiti d’onore legati al merito, intervento crescente delle istituzioni private nelle politiche di formazione e ricerca, aumento della competizione per l’accesso ai finanziamenti, esercizi di valutazione con cui le università possano dimostrare ai taxpayers di avere speso bene il denaro. Se questa interpretazione è corretta, la battaglia è davvero molto dura, perché comporta una radicale messa in discussione dei meccanismi che governano il nostro mondo, non solo a livello materiale ma anche e soprattutto culturale. La prima cosa da fare è rendersi conto che certe cose non sono fatti di natura ma prodotti della storia, non eventi fatali o necessari ma risultato di precise scelte politico-economiche. Per questo bisogna subito rovesciare il famoso slogan della signora Thatcher: there is alternative.
SUDCOMUNE: Dopo aver rilevato, con Readings, la perfetta assimilazione del sistema universitario alla logica neoliberale e alle leggi del mercato mondiale affermi che ci sono tre dispositivi centrali che governano la nuova università: misurazione, informatica e burocrazia. Puoi illustrarci in che senso queste tre dimensioni assumono la funzione del dispositivo?
FB. Nella mia analisi, ampiamente corroborata dall’esperienza, le varie articolazioni dell’apparato collaborano perfettamente e trovano un punto di integrazione a vari livelli: economia, organizzazione, tecnologia, psicologia, sistema di governo. L’enorme espansione della macchina burocratico-amministrativa, supportata da una riforma della governance in senso sempre più oligarchico e tecnocratico, si avvale di alcuni strumenti che ormai colonizzano potentemente e capillarmente la nostra esperienza quotidiana di ricercatori e insegnanti: parametri di misurazione inevitabilmente arbitrari e fallibili, ma spacciati per oggettivi; equazione tra responsabilità (accountability) e contabilità (accounting); uso estensivo delle tecnologie informatiche e dei sistemi di elaborazione dei dati in cui la statistica diventa un’arma impropria, trincerata dietro l’apparente neutralità dei numeri ma invece asservita a determinati interessi e obiettivi. Siamo perfettamente calati in una dinamica pirandelliana per cui accedi all’esistenza solo in quanto funzione astratta del sistema. Ad esempio, studiosi e docenti esistono in quanto tali solo se si sottopongono alle procedure di valutazione che ne riconoscono il ruolo, che ne stabiliscono la quotazione sul mercato intellettuale della ricerca, che li collocano in una gerarchia ideologicamente condizionata ma travestita con l’apparente oggettività dei parametri tecnici (numeri, punteggi, algoritmi). Posso anche scrivere e pubblicare La critica della ragion pura, ma finché non apro l’applicativo informatico e non compilo la scheda descrittiva del “prodotto” con dati e metadati, abstract e parole-chiave, codici e pdf, quella pubblicazione di fatto non esiste. Anche qui peraltro vige la logica dell’accumulazione capitalistica, compendiata nello slogan di un nuovo darwinismo sociale applicato alla vita accademica: publish or perish, o addirittura publish and kill: devi pubblicare freneticamente per vincere la sfida della competizione, scalare le classifiche, ottenere finanziamenti, totalizzare prodotti e citazioni come i tossici da social network che vivono solo per arricchire il bottino di likes e followers.
Da questo punto di vista, e secondo una dinamica che non riguarda solo l’università ma gran parte delle nostre pratiche sociali, le intuizioni di Foucault mi sembrano perfettamente centrate, soprattutto per quanto riguarda l’interiorizzazione del dispositivo da parte dei soggetti, spinti ad agire compulsivamente e a rispondere puntualmente alle ingiunzioni dell’apparato. È il paradosso di ubbidire volontariamente a un comando, meccanismo primario di quella che una volta si chiamava alienazione. Per questo utilizzo l’immagine dei “piccoli fratelli”, evoluzione foucaultiana di uno dei grandi totem ideologici dell’immaginario novecentesco: non c’è più un’istanza di controllo unica e oppressiva, fonte di inquietudini e deliri paranoici, un Grande Fratello che controlla le nostre vite da qualche occulta centrale del potere. Perché quel controllo viene delegato a noi, alle nostre protesi tecnologiche sempre più invasive e potenti, a un sapere tanto più esteso quanto più incapace di far presa sull’esperienza. Perché i piccoli fratelli siamo noi.
SUDCOMUNE: Quando parli della Betise accademica utilizzi la categoria foucoltiana di microfisica in quanto reticolo di relazioni, pratiche e strutture non evidenti, strumenti di microregolazione che vengono interiorizzati dagli stessi soggetti. Aggiungi appresso che «La governamentalità dell’attuale mondo accademico si basa infatti su un sistema di potere miniaturizzato, tanto stupido quanto efficace disseminato in una microfisica di pratica quotidiane di cui siamo al tempo stesso attori, vittime e complici». Un’altra categoria foucoltiana, cara a sudcomune, che adoperiamo nei nostri esercizi d’inchiesta, è quella di “produzione di soggettività”. Dei docenti abbiamo già accennato, vorrei adesso chiederti come, secondo te, la microfisica del mondo accademico influenza la soggettività degli studenti?
FB. Credo che lo faccia in modo meno esplicito e strutturato, ma altrettanto efficace. Pensiamo a un aspetto di cui ho già parlato, cioè la mutuazione di logiche economiche da parte dei sistemi educativi, e in particolare da questa neo-università. È un aspetto che incide moltissimo anche sulla mentalità e sulla soggettività degli studenti. Il problema infatti non è tanto l’ingresso di interessi commerciali nel mondo accademico, un fenomeno più o meno massiccio a seconda degli ambiti disciplinari e delle aree geografiche, ma la metamorfosi del sistema nelle sue strutture profonde, nella mentalità comune, nelle tecnologie di governo, nello stesso linguaggio. Quando inserisci gli studenti in un sistema che propone una “offerta formativa”, modellata presumibilmente in funzione di una “domanda”; quando contabilizzi il loro apprendimento in “crediti” e “debiti”, accumulando le competenze acquisite in una “carriera”; quando sottoponi loro dei questionari di valutazione della didattica concepiti secondo il modello della soddisfazione del cliente, in cui esistono domande come “il carico didattico dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?”; beh, è evidente che modelli la loro percezione dello studio e della cultura in un’ottica precisa, in cui tutto è (o dovrebbe essere) misurabile, rapido, diretto al risultato, in cui non c’è spazio per quelle facoltà prettamente antieconomiche che sono alla base della vera conoscenza: curiosità, azzardo, inventiva, sforzo disinteressato, disponibilità al rischio e alla sorpresa. Insomma, un’idea della formazione scientifico-culturale come prodotto e non come processo. È questo il significato del sottotitolo del libro: “la cultura in scatola”: un sapere impacchettato e confezionato come un prodotto da esporre sugli scaffali, mentre quello che era un diritto (allo studio, all’ascesa sociale, al miglioramento di sé) si trasforma in una merce come un’altra.
In questo però conservo un fondo di ottimismo: penso che molti studenti siano migliori di come li dipinge una certa retorica del buon tempo antico, perché i giovani d’oggi sono ignoranti e svogliati, non studiano e non hanno basi, signora mia. Non è affatto vero, almeno non in modo assoluto, e soprattutto non in modo ineluttabile. Se nell’universo sociale non esiste nulla di naturale, gli studenti tendono a comportarsi in base al sistema che noi abbiamo costruito: fanno quello che noi li induciamo a fare: ridurre, semplificare, comprimere i tempi, finalizzare tutto al risultato, non leggere una virgola in più rispetto al monte crediti da accumulare. Ma questo sistema può essere disinnescato dall’interno. Bisogna solo avere la voglia e il coraggio di farlo, confortati dal fatto che molti studenti, se adeguatamente stimolati, capiscono e rispondono benissimo. Se torniamo infatti al perché di certe trasformazioni, e anche alla domanda molto complessa sul chi abbia deciso e portato avanti certe scelte, ci rendiamo conto che lo studente-capra del cliché, quello che pascola stolidamente nelle aule per poi collocarsi in una postazione sociale qualunque, è perfettamente congeniale a una certa visione della politica e della società, quella che chiede a scuola e università di sfornare individui passivi, disciplinati, intellettualmente amorfi, politicamente docili e malleabili. Quanto a me, finché avrò forza in corpo, cercherò di educare studenti “resistenti”, forniti di senso critico, capaci di esercitare il dissenso e di pretendere un orizzonte migliore per le proprie vite. E in questo, nonostante il senso di scoramento da cui ogni tanto mi faccio prendere, sento di avere ancora una lunga guerra da combattere.
SUDCOMUNE: Un aspetto di Universitaly che mi è sembrato particolarmente interessante, nonché poco affrontato, riguarda lo storytelling che si è venuto a consolidare – grazie anche alla “selettiva ignoranza dei giornalisti” – riguardo alla attuale situazione accademica: «i fatti, i concetti, i meccanismi giuridici, gli stessi termini vengono spesso utilizzati in modo superficiale e approssimativo, con un effetto di semplificazione che non attiene solo alle leggi basilari del giornalismo ma che sembra congeniale a una narrazione più vasta e organica». In questa narrazione ci sono alcune “parole magiche” (merito, valutazione, eccellenza) che la sostengono potentemente e che formano quella che possiamo chiamare nuova ideologia dell’università. Vuoi raccontarci, a partire da ciò, in cosa consiste l’attuale ordine del discorso universitario, quello che definisci come “master fiction”?
FB. È uno degli aspetti che mi stava più a cuore, che per certi versi intercettava maggiormente i miei interessi e le mie competenze di studioso del linguaggio e in particolare della comunicazione narrativa. La master fiction è una narrazione egemone, un discorso del potere che seleziona certi elementi narrativi, ne sopprime altri, costruisce trame e schemi retorici particolarmente efficaci che vengono imposti e sanzionati con il sigillo della verità. Come spiego in uno dei capitoli del libro, ad esempio, la Legge Gelmini non sarebbe mai stata approvata se non fosse stata accompagnata da una poderosa strategia narrativa (il termine di moda è appunto storytelling) che ha distorto e manipolato i fatti, a partire dalla mossa geniale di presentare come “riforma antibaronale” un provvedimento legislativo che ha rafforzato il potere al vertice, ha consolidato la gerarchia accademica e ha terribilmente peggiorato vizi endemici dell’università come il servilismo, il conformismo, la ricattabilità e l’arbitrio di una ristretta oligarchia.
Come ricordi tu stesso, le tre parole magiche della nuova università (ma è un discorso che potrebbe essere esteso ad altri ambiti) sono “merito”, “eccellenza” e “valutazione”, termini che sottopongo a un processo di “critica distruttiva” per smascherare il progetto politico che veicolano: un progetto intimamente classista, reazionario, antiegualitario, che fa tristemente regredire l’Italia repubblicana rispetto alle conquiste dei decenni precedenti. Nel generale senso di impotenza e nella chiusura inesorabile degli spazi di azione politica, credo che questo sia uno degli ambiti strategici su cui lavorare, sia all’interno dell’università, tra docenti e studenti, sia nell’orizzonte più ampio dei media e della pubblica opinione: far capire cioè che lo storytelling egemone nasconde una faccia oscura, che dietro la trama ufficiale ed euforica (attraverso sistemi di valutazione trasparenti premieremo i meritevoli e gli eccellenti) c’è una trama rimossa, clandestina, inconfessabile, di cui molti non hanno alcuna consapevolezza: in realtà premieremo solo chi – per condizioni favorevoli di partenza – è già in condizione di riuscire, perché in assenza di pari opportunità la meritocrazia è un sistema produttore di ingiustizia sociale, come peraltro aveva preconizzato l’inventore del termine, il sociologo inglese Michael Young, in una satira politica intitolata The Rise of the Meritocracy.
SUDCOMUNE: Il tuo punto di vista sull’università è quello di un professore “resistente”, nel senso che in effetti proponi una visione differente, se non antagonista, a quella di molti tuoi colleghi. Da quanto scrivi emergono infatti nel corpo docente due visioni contrapposte dell’università, come se la mission non fosse condivisa. Semplifico, estremizzando, per maggiore chiarezza: da un lato ci sono i professori che lavorano per gli studenti, per sviluppare il senso critico, insegnare a decostruire i meccanismi ideologici che ci governano, fornire gli strumenti per mettere in discussione il nostro stesso sapere. Da un altro lato ci sono i professori burocrati, che lavorano soprattutto per se stessi, che compilano griglie ed eseguono procedure formalizzate da altri, che utilizzano l’ambiguità dei meccanismi quantitativi di valutazione per la propria carriera personale anche se a scapito della reale qualità dei loro insegnamenti. E’ cosi? C’è una mission vincente ed un’altra resistente? Vuoi aggiungere qualcosa in merito?
FB. In realtà non è così semplice, lo schema non è così nettamente manicheo. Nessuno può chiamarsi fuori. Chiunque stia dentro, anche se cerca di farlo in modo critico, è complice e responsabile di ciò che è successo. È una postura che, più o meno esplicitamente, rivendico in ogni pagina del libro e che a un certo punto esprimo attraverso un’immagine: segare il ramo su cui stiamo seduti. Detto ciò, penso che non riuscirò mai a sbrogliare il profondissimo mistero della psicologia sociale dei docenti universitari, per la quale ci vorrebbe una seduta analitica generale, una terapia di massa che metterebbe in crisi perfino Sigmund Freud. Mi colpisce soprattutto che tanta rassegnazione, indifferenza, conformismo, opportunismo, pigrizia o vigliaccheria si manifestino proprio in persone che dovrebbero dedicare la loro vita alla ricerca, al sapere critico, alla decostruzione dei luoghi comuni, guidati da facoltà ingovernabili come la curiosità, l’ironia, l’autonomia del pensiero e del giudizio. Lo dico a ragion veduta, senza chiamarmi fuori, con l’esperienza di chi ha vissuto in prima persona queste “passioni tristi”, come le chiamerebbe Spinoza, e che ha cercato quotidianamente di scacciarle dal suo animo con battaglie incerte e sfiancanti.
È per questo che nel libro, quando tento di evocare i connotati morali della vita accademica, utilizzo quella figura che Primo Levi ha chiamato “zona grigia”, quando descriveva, certo in un contesto infinitamente più tragico ma esteso alla generalità del comportamento umano, la «necessità quasi fisica che dalla costrizione politica fa nascere l’area indefinita dell’ambiguità e del compromesso». La vischiosità di questo orizzonte è ciò che rende impossibile l’unica riforma di cui ci sarebbe davvero bisogno: una riforma “morale”, ostacolata non tanto da problemi tecnici (a partire dalla disquisizione infinita sulle regole dei concorsi) ma da un’ambiguità etico-politica che rende sempre difficile prendere posizione, esercitare il diritto al dissenso, smarcarsi da un sistema spesso corrotto che ha un formidabile potere di contagio e che riesce a rendere tutti corresponsabili. Forse, per chi ha un minimo di autocoscienza, il senso di rassegnazione e impotenza viene anche da qui, dal sentirsi comunque responsabili di uno sfascio, gente che magari non ha fatto attivamente nulla di male ma che non ha avuto la forza o il coraggio di denunciare ciò che vedeva intorno a sé.
Questo per dire che è difficile tracciare uno spartiacque netto tra apocalittici e integrati, collaborazionisti e resistenti. Ognuno di noi è parte del sistema, collabora più o meno attivamente a farlo essere quello che è. Non faccio l’anima bella, né ho alcuna velleità moralizzatrice e fustigatrice nei confronti di colleghi che sembrano molto più integrati nella macchina, e spesso anche apparentemente felici di esserlo, beati loro. Vorrei solo richiamarli, mentre richiamo me stesso, a un’idea di cultura autentica, disinteressata, svincolata da obiettivi e interessi contingenti, finalizzata al miglioramento degli individui e all’accrescimento del benessere generale, tutti ideali che questa università sta clamorosamente rischiando di tradire. Ogni tanto, mentre compiliamo schede astruse o scriviamo progetti complicatissimi per cercare disperatamente dei finanziamenti, dovremmo ricordarci che ci sono solo due cose che siamo davvero tenuti a fare, in quanto funzionari dello Stato pagati con denaro pubblico: studiare con passione e insegnare meglio che possiamo ai nostri studenti. È questa l’unica missione a cui dovremmo finalizzare il nostro tempo e le nostre energie. Tutto il resto è aria fritta.
SUDCOMUNE: Al termine del libro fai una sorta di decalogo per il “bravo” professore: non avere paura; prendi la parola; parla con loro; non farlo; non abituarti; rallenta; smaschera; gioca al rialzo; non trattarli come clienti; insegna il dissenso. Sono consigli che ritengo molto importanti e ai quali sento di aderire. Ma qual è, secondo te, il decalogo (punto più, punto meno) dei suggerimenti per il “bravo” studente?
FB. Alcune pratiche di resistenza potrebbero essere le stesse anche per gli studenti. Sicuramente «prendi la parola» e «parla con loro», visto che anche nel corpo studentesco, da alcuni anni, è in atto un forte processo di involuzione politica che ha neutralizzato la possibilità stessa dell’organizzazione collettiva e del dissenso. Anche qui, non casualmente, il momento del riflusso coincide con l’approvazione della Legge Gelmini, che è stato il fondamentale spartiacque di questo nuovo corso. Se devo giudicare dall’osservatorio di Bologna, la situazione è davvero sconfortante: una stretta autoritaria al vertice, con interventi sempre più invasivi e inquietanti dell’autorità giudiziaria, spesso del tutto sproporzionati rispetto ai fatti; una frammentazione dei movimenti studenteschi in piccoli gruppi sempre più litigiosi e radicalizzati, che mettono in atto pratiche politiche magari condivisibili nel merito ma controproducenti nei mezzi utilizzati, funzionali al consenso collettivo rispetto alle manovre repressive; e nel mezzo un vasto deserto: la maggior parte degli studenti abbandonati a se stessi, privi di un tessuto connettivo politico o semplicemente comunicativo, in balia degli stessi (dis)valori che ormai dominano completamente l’università e forse la società intera: individualismo, competizione, efficienza, concorrenza.
Un’altra pratica fondamentale, simmetrica a una di quelle che individuo per i docenti, è «gioca al rialzo»: credi in te stesso, rilancia, rischia, esplora, non avere paura del “carico didattico”, fai un passo in più rispetto a quanto ti viene prescritto dai programmi, dal computo dei crediti o dai “risultati di apprendimento attesi”; ricordati che il sapere non si misura, che la scoperta scientifica eccede sempre i nostri calcoli e le nostre previsioni; e fai come Saul, che era uscito di casa per cercare le asine di suo padre e invece trovò un regno. Più in generale (e questo può essere un altro punto), «reclama diritti»: ricordati che quello al sapere è un diritto sancito dalla Costituzione, non una merce da scambiare sul mercato di questo nuovo business che si chiama appunto “Universitaly”, in cui l’eccellenza è solo il marchio con cui attirare gli allocchi e mettere sugli scaffali presunti prodotti di qualità a prezzi gonfiati. Altro consiglio, «pretendi attenzione»: chiedi ai tuoi professori delle buone lezioni, una vera disponibilità al dialogo e all’ascolto, una seria dedizione nel correggere le tesi di laurea. Forse solo così, con l’aiuto critico e partecipe degli studenti, anche i docenti potranno uscire dalla spirale di sconforto, frustrazione e rassegnazione in cui li vedo tristemente avviluppati.