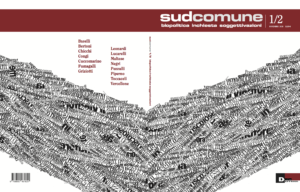Pubblichiamo la recensione di Cesare Milanese scritta in occasione della traduzione italiana di “The Uman Drift” (1894), un testo di King Camp Gillette, socialista utopico, inventore del rasoio e fondatore dell’omonima multinazionale. Il Turbine Umano (Elemento 115, Roma 2018; traduzione e cura di Vanni De Simone) verrà presentato a Roma in Campo De Fiori il 18 ottobre 2018 (ore 18.00, Libreria Fahrenheit)
di CESARE MILANESE
1. E’ in nome di the wonderful possibilities of man’s progress in the future, che King Camp Gillette scrive (nel 1894) Il turbine umano (The Human Drift): tradotto ora (2018) per la prima volta in Italia da Vanni De Simone, che ne è curatore, prefatore, commentatore e anche propositore convinto, a ragione.
De Simone traduce quella frase citata in inglese valendosi della citatissima espressione usata da Giacomo Leopardi sulle “magnifiche sorti e progressive”. Là dove si sa che il poeta della Ginestra, o fiore del deserto, usa tale frase a conferma della dichiarazione di sfiducia, a matrice saussuriana, sul contributo del progresso al miglioramento della società con il far passare l’umanità dalla “condizione infelice” a quella, se non proprio felice, almeno fiduciosa. E si sa che no.
Sta di fatto che De Simone traduce così l’inizio del libro di Gillette: “Il quarto centenario della scoperta dell’America è arrivato e trascorso, ed è stato celebrato con adeguate cerimonie e un generale e popolaresco sentimento di gioia. Suo scopo finale pratico era di risvegliare nelle menti di ognuno ‘le magnifiche sorti e progressive’ dell’umanità del futuro.”
Ottima traduzione-interpretazione, che non nega la problematicità delle visioni troppo ottimistiche sul contributo trasformativo in senso progressivo, appunto, delle “scienze e delle arti” (su cui, pertanto, tutte le utopie, soprattutto quelle della Modernità fondano la loro sicurezza), ma al tempo stesso nutre lo stesso la convinzione “fidente” sulla realizzabilità della “ottimizzazione” della civiltà promessa, sia pure prefigurata nella “descrizione” che ne può dare, nel “per ora”, una concezione nella forma dell’utopia.
Attenzione di positività, quest’ultima, che è propria di King Camp Gillette, sia come propositore di una concezione utopica e sia come imprenditore il quale ha scoperto che la via delle scoperte del progresso tecnico è anche la via dell’avvio di una concezione utopica dai risultati concreti, parziali si sa, ma anche realizzabili subito, ora. E qui va detto che su questa linea d’attenzione positiva nella funzione dell’ideazione di progressività a matrice utopica, Vanni De Simone viene trovarsi in sintonia, sia come studioso, sia come scrittore e sia come “politico”, convinto della necessità della tensione utopica come spirito della politica. E’ per tale convinzione che si è fatto anche editore delle collane di Elemento 115 con libri prevalentemente rivolti al futuribile, riprendendoli filologicamente dal passato e ripresentandoli per la loro virtualità attuale.
2. E’ il caso de Il turbine umano di King Kamp Gillette (1855 – 1932), il capitalista magnate e industriale di portata mondiale della sua invenzione d’importanza mondiale: il tipo di rasoio che porta difatti il suo nome. Ebbene, questo suo libro, è un libro d’utopia. Gillette non si è accontentato di essere un progettista realizzatore, sia in senso tecnologicamente innovativo, ma anche industrialmente produttivo, di una sua invenzione, secondo lo spirito proprio della Modernità che esige gli esiti reali. Gillette intende porsi come inventore e progettista di un modello di realtà sociale muovendo dai presupposti che sono propri dell’utopia. Intende porsi, pertanto, come progettista dei mutamenti propri della storia in generale ai fini della sua stessa razionalità storica.
D’altronde il concetto della realizzabilità di tutto ciò che costituisce razionalità è il “punto forte” di ogni concezione utopica. Può sembrare un paradosso, ma non lo è. E il “sistema” di società, previsto da Gillette vi si associa proprio in questo senso. Nel suo caso, più in particolare, muovendo dalla condizione concreta della società entro la quale egli opera (ha già operato) come imprenditore e come inventore, pertanto come “inventore” di un insieme, prima settoriale, poi generale, che poi può diventare globale: diciamo pure totale. Essendo questa l’escalation che costituisce la genesi di ogni utopia. Diciamo che l’utopia è un fattore interno della Modernità nella sua spinta verso la Postmodernità. Quindi un fattore che, considerandolo storicamente, ha agito sempre e continuerà ad agire sempre.
Gillette, in modo ancora più specifico ed esemplare si rifà alla condizione umana (la sua società, quella americana) data nel proprio tempo: quella della società americana a cavallo dei due secoli, di cui si propone di dare l’avvio a un movimento di avanzamento liberatorio, che ha per protagonista (di tale avanzamento) l’uomo stesso, che per sua natura è prima di tutto homo faber: il lavoratore-produttore in sé, operaio o imprenditore, proletario o capitalista che egli sia. Suddivisione – divisione, questa, da potersi considerare come “istituzione costitutiva” che potrebbe rendere superabile la lotta di classe: “Grazie alla Eguaglianza Materiale e all’Unione delle Intelligenze fattive e inventive” (sono parole dello stesso Gillette), che abbia per fine lo stato di equivalenza, nel senso di uguaglianza, che è la condizione che spetta all’ordinamento umano nella sua completezza, materiale, morale e ideale.
In quale modo? Per quale via? De Simone sintetizza così il pensiero di Gillette: “Per Gillette la soluzione dei mali del capitalismo stava nel capitalismo medesimo, e aveva un nome preciso: corporation, società per azioni. Ovviamente dovevano cambiare i soggetti della sua gigantesca corporation (tutto in Gillette è gigantesco), ma non la corporation in quanto tale, che non sarebbe più stata la creatura di pochi ricchissimi investitori ma di tutto un popolo, una SpA ad azionariato popolare, proprietà di tutto il popolo, e facente gli interessi di tutto il popolo. Le diede vari nomi, non facilmente traducibili in italiano perché se ne diminuirebbe la forza evocativa: United Company, People’s Corporation, World Corporation – ma tutti, secondo la sua visione, riconducibili a uno stesso concetto, e cioè che solo la potenza di questa specifica forma societaria avrebbe potuto curare le malattie economiche e sociali dell’America.”
Come a dire che in tale prospettiva sarebbe dato di intravedere, sempre citando De Simone, che “la soluzione dei mali del capitalismo sta nel capitalismo medesimo”. Soluzione che nel “sistema” di Gillette potrebbe essere tutt’altro che irrealistica. Gillette, nella sua ipotesi da Società per Azioni Collettiva, si rivelerebbe, difatti, un realista, perfino predittivo sull’oggi: se volessimo ammettere che lo sviluppo del capitalismo odierno, nell’era della globalizzazione, potrebbe avere in sé le premesse, se non del proprio rovesciamento totale (l’ipotesi, in grande, quella della Rivoluzione di un tempo), certamente quelle di un proprio “cambiamento”, comunque totale. Per Gillette: The Change (ipotesi in grande anche questa).
E ciò in virtù della formula individuata da De Simone nel sistema elaborato da Gillette: che cioè, “la soluzione dei mali del capitalismo starebbe nel capitalismo medesimo”, entro il quale anche la “vecchia talpa” della Rivoluzione potrebbe avere la sua funzione (una volta che The Change potesse essere inteso come La Rivoluzione e viceversa). Qui, magari, si tratta soltanto d’intendersi sulla terminologia: una volta che la Rivoluzione sia denominata come Transizione, l’intendere tale Transizione come “cambiamento” (come Change) potrebbe valere come assunzione di un metodo di elaborazione teorica comunque proficuo (da non confondersi, però, con ciò che un tempo andava sotto il nome di revisionismo; da intendersi, questo, come rinuncia al ricorso di un’Azione Diretta complessiva, che “nei tempi andati” andava sotto il nome di Rivoluzione).
Intesa in questo senso, la questione dell’Azione Diretta, della Rivoluzione stessa, perciò, rimane aperta lo stesso. E questa sì che è una bella questione. E il “difetto” di ogni utopia è stato sempre quello (sarebbe tuttora sempre quello) di stabilire se all’Ordine Perfetto delle cose si debba passare attraverso l’Apocalisse o no: e soprattutto se il moto apocalittico potesse essere tuttavia, pur sempre, o no, il motore di ciò che dovrebbe essere l’Ordine Perfetto, finalmente raggiunto.

E questa è una questione (Rivoluzione e/o Change, e in quale quantità e fino a che) che il lettore è costretto a porsi come il “sotto traccia” del libro di Gillette: e questo perché Gillette non è un utopista astratto, ma l’uomo proto tipico della Modernità con propensioni interne dovute al “sogno-disegno” o al “disegno-sogno”, ineliminabile, dell’utopicità.
Sta di fatto che il fare e il dire di Gillette fanno fare subito un balzo associativo con i casi Ford e Rathenau. Se poi ci si mette in mezzo anche un Keynes, allora si capisce che il mondo è comunque ancora tutto (per tutti) in pieno attraversamento di un guado che, chissà, se sarà del tutto attraversato. Intanto, tanto per effettiva vulcaneria produttiva quanto per ipoteticità d’utopia, le due “energie” muovono gli ingranaggi del reale procedendo insieme.
3. Change, peraltro, sarebbe la parola-guida di tutti gli “utopisti-realistici” (alla Charles Fourier e alla Saint – Simon, con i dovuti distinguo), per i quali il Mutamento nel senso da loro intravisto starebbe nell’ordine “naturale” delle cose. Vi si contrappongono gli “utopisti apocalittici” (alla Babeuf-Blanqui: perché tali sono) per “impazienza rivoluzionaria” (per errore di metodo). Peraltro, se poi si prendono in esame gli stessi padri fondatori del marxismo (tutt’altro che utopisti), quali Eduard Bernstein e Karl Kautsky, si scopre che il loro metodo corrisponde a quello degli utopisti realistici. Tutto potrebbe compiersi da sé: essendo già effettivi gli “schemi” sui quali il corso delle cose troverà, per l’appunto, il proprio corso. E il criterio adottato da Gillette è riconducibile, grosso modo, a questa mentalità-matrice, comune ai “realisti” e agli utopisti.
Se è così, allora è evidente che King Camp Gillette si colloca nell’elenco degli “utopisti realisti” e che la sua idea di società “equilibrata” si propone come un modello di congiunzione riuscita tra utopismo e realismo: come se l’utopismo fosse da intendersi quale funzione complementare del realismo e come se il realismo debba essere inteso quale funzione complementare dell’utopismo. Ciò sembra essere la formulazione di un paradosso, che in parte lo è e in parte non lo è (con l’utopismo la paradossalità vige comunque sempre).
Inoltre è perfettamente constatabile che realismo e utopismo sono componenti comunque compresenti nella realtà politica effettiva, quale che sia la matrice ideologica che vi presiede. Il fatto è che tutte le politiche, anche le meno utopiche, recano in sé una componente utopica come fattore della propria “propulsività”. Il fattore “energia” deve esserci sempre. A volte, per suscitarla, è sufficiente pensarla. E’ questa la grande “trovata” dell’utopismo: un idealismo che passa subito all’atto, e ci riesce, sia pure soltanto in parte, ma a volte anche questo “soltanto” è ciò che basta al ciò che veramente è.
Va precisato, tuttavia, che a differenza, sia dei maggiori e sia dei minori, costruttori di visioni o visionarietà utopistiche, prevalentemente orientati a concepire i processi delle loro elaborazioni entro un orizzonte marcatamente collettivo delle stesse, Gillette si colloca, evidentemente anche per via della sua pratica ed etica dell’homo faber (da lui, peraltro, impersonato proprio “personalmente”) entro una concezione prevalentemente soggettivistica e volontaristica. Come a dire che la dinamica del Cambiamento ha il suo centro nella presa di coscienza dell’individuo quale homo faber, però nella sua dimensione individuale, da imprenditore quale soggetto dell’azione settoriale diretta, quantificabile e controllabile, atto per atto, dalla stessa soggettualità. E ciò sul presupposto, sottinteso, per cui, un pensatore utopico è portato a estendere la propria “invenzione”, completandola anche come modello – progetto, idoneo a essere applicato, pronto all’uso.
Si dà allora il caso che, proprio per esigenza di completezza, il visionario utopista, intendendo sottrarsi alla dimensione della sola visionarietà, tende a configurare il suo disegno di società “coerente” dettandone la precettistica e “disegnandone” perfino l’iconologia esteriore. Gillette, dopo aver elaborato, come testo scritto, la sua prospettiva di società, ne disegna anche la configurazione architettonica e urbanistica. In altri termini tenderebbe, sempre per spirito di completezza, a farsi anche imprenditore edilizio, sia pure ideale, giacché nei suoi disegni da progetto edilizio (mica tanto estetici, a dir il vero) vi si può scorgere una propensione all’idea di una “città, o civiltà, ideale”. E De Simone lo dice.
Certo, King Camp Gillette, come inventore, imprenditore e capitalista coincide con l’homo faber; come utopista e umanista quasi socialista coincide con l’homo philosophus. Due tipologie costitutive che possono benissimo convergere. Tanto è vero che egli pensa in questo senso. Le “contraddizioni” insite in tale approccio, non le avverte. Egli si fida nella propria volontà d’operatività da far procedere comunque. Homo faber fino in fondo nell’ergersi come controllore economico della società tutta, estende questa sua competenza di controllo anche alla forma dell’habitat di tale società. E qui si trova, coerentemente, a ripercorrere le orme di tutti i grandi” dell’utopia. Charles Fourier lo aveva preceduto con la progettazione del Falansterio. La “Città Ideale” in senso rinascimentale o la “Città-Metropolis” in senso da fantascientismo dell’immaginario più attuale? De Simone, nella sua introduzione al libro, si chiede anche questo. Ce lo chiediamo anche noi, come lettori generali, e non possiamo non dichiararci convinti che la progettazione di società avanzata da Gillette, se da una parte costituisce problema da teoria (diciamo così) sociologica, da un’altra parte mostra di poter essere interpretata come suggerita da una visionarietà tipicamente fantascientifica, la cui matrice è esplicitamente di origine letteraria.
E se ne capisce anche il perché, estensibile, infatti, a tutti i costruttori di utopie. Giacché è innegabile che tutti gli utopisti, nelle loro argomentazioni e nelle esposizioni delle loro ragioni a sostegno del proprio disegno utopico, non possono eludere la descrizione dei risultati delle loro teorie se non con delle vere e proprie narrazioni, che sono di per sé narrazioni di romanzo. Un utopista è sempre, in parte, un romanziere storico a possibile futura memoria. Magari si tratta soprattutto di un’esposizione che rinvia alla paraletteratura, certo, ma sta di fatto che, in ogni “fantasia da utopia”, più o meno bene espressa, l’impronta letteraria c’è. E ci sta.
Potrebbe sembrare paradossale, da argomentazione forzata, voler considerare un’elaborazione utopica come questione attinente anche alla letteratura, di cui potrebbe costituire un genere particolarissimo, anche se non classificato come tale. Ma lo è, prima di tutto perché è un’invenzione che muove dall’immaginario e continua a essere, nella sua stessa argomentazione, una descrizione che, certamente, intende riferirsi al reale e a costituire una questione reale, però in un futuro che, per ora, non c’è: sta scritto sulla pagina e come tale resta una descrizione immaginaria. Se immaginaria, allora anche letteraria. Va da sé.

4. All’inizio si è citata la ben nota scettica frase di Giacomo Leopardi, che reca in sé la sentenza inesorabile sul destino finale della specie umana: se basta “un lieve moto” fisico della natura (“la dura nutrice”), che ha il suo simbolo nello “sterminator Vesevo”, per ridurla al nulla. Vale per la natura, ma per ciò stesso vale anche per la società umana e per la storia, anch’essa, come tutto, “Vesevo” di se stessa. Perché è in ciò che, alla fin fine, convergono “delle umane genti / le magnifiche sorti e progressive”: le quali non sono né magnifiche né progressive. O meglio non sono per niente magnifiche, proprio perché pretenderebbero di essere progressive. Semmai, per Leopardi, invece, sono, al contrario, regressive: e per di più irrimediabili. E’ vano immaginarsele rimediabili.
Ma Leopardi è un poeta. E i poeti, contrariamente a quello che generalmente si pensa, sono i grandi oppositori dell’utopia. Si rileva, infatti, che su questa matrice leopardiana, evidentemente avversativa a ogni ricorso alle consolazioni utopiche, in politica e no, vengono a trovarsi concordi quasi tutti i grandi poeti della Modernità, per i quali il mondo, per l’umanità, non è che una “terra desolata”. Eliot deve la sua fama a questa sua sentenza: che poi egli ci immetta l’aspirazione alla redenzione spiritualistica è indizio di una misticità che, semmai, aggrava anche di più la sua convinzione sulla “negatività” della realtà, che nessuna positività da politicità può mai riscattare. L’elenco dei poeti della Modernità, in proposito, è lungo, lunghissimo: li comprende quasi tutti, i grandi. Qui ci si limita alla citazione dei nomi più decisivi, sparsi a caso: Edgar Allan Poe, Samuel Coleridge, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Samuel Beckett, Louis-Ferdinad Céline, Paul Celan, Thomas Berhhard… Poeti e prosatori assieme, ma in questo caso si tratta dei prosatori particolarmente “poeticistici” nei loro risultati.
Per i poeti della Modernità, l’umanità non ha scampo dalla negatività della realtà. E tanto meno c’è, tale scampo, perfino nell’astrattismo, da intellettualismo estremo, di un Paul Valéry, che il problema della “messa in salvo” dell’uomo dalla condizione umana reale non se lo pone nemmeno: se non come élan del vivere come vivere (più come questione di assunzione di una forma piuttosto che di un contenuto d’esistenza). L’anima dell’utopia, negli autori “poetici” della Modernità, è un fattore assente. Sotto quest’aspetto la Modernità, nella sua massima poeticità, è una Lamentatio Magna sul mondo, al destino del quale non è previsto, neanche in futuro, il remedium, che ogni concezione utopica, invece, anticipa e prescrive, con una certezza da fede indubitabile (pur trattandosi di una fede fondata su una “ragione politica” ragionata: ma sia sa, l’utopismo è pur sempre un illuminismo).
Mentre, al contrario, invece (ed è questo un motivo da sorpresa), lo spirito dell’utopia è dichiaratamente presente (o almeno in qualche modo presente), semmai, negli autori classificabili nel versante dei “filosofi”. Difatti sono da sempre i filosofi che si fanno propositori e costruttori di Utopie: da Platone a Tommaso Moro, da Tomaso Campanella a Fourier… L’elenco anche questa volta è assai lungo in tutte le enciclopedie, con questa indicazione di singolarità di un dato: sono i “filosofi”, da sempre, i propositori e i costruttori delle utopie, considerate comunque salvifiche. Sia pure mettendo da parte i più radicali e terribili di essi: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, e i loro consimili, gli esistenzialisti “puri”, gli “scrittori” da “filosofie della vita” (materia, difatti, da soggettività dell’individualità, pertanto materia da poeti).
E, a margine, si può dire che quasi tutti i filosofi della Modernità e della Contemporaneità, pensatori ed elaboratori delle “filosofie della generalità”, una qualche componente dell’utopicità ce l’hanno tutti: Karl Marx compreso, per esempio, il quale, peraltro, sarebbe anzi il più scientifico e il più “positivista” (leggasi materialista, secondo la terminologia della vulgata) di tutti gli utopisti di sempre. Osservazione, questa, che in questo contesto, intende essere un elogio.
Anche Marx, un “utopico”? E come no! Marxisti e immanentisti, a tal proposito, sono dei teleologici non meno che dei trascendentalisti. Ne fa da esempio esplicitamente dichiarato, quello di Ernst Bloch, comunista nell’era della maturità del pensiero marxista, che nel 1918 scrive un libro che ha per titolo Spirito dell’utopia: punto vi vista positivo sulla funzione dell’utopismo, confermato del resto in tutta la sua opera, che tiene conto, peraltro manifestamente, della tensione utopica in un altro suo libro fondamentale, nel 1968, Ateismo nel cristianesimo. Libro tutto impostato sul “principio speranza”: vale a dire sulla “coscienza anticipante dell’uomo”, che è ciò che costituisce il motore morale dell’azione verso la Rivoluzione, che si avvale, perciò, della categoria dell’utopico come programma politico futuribile ma perseguibile come guida, sia interiore e sia esteriore, dell’uomo “rivoluzionario”.

Ottimismo dell’intelligenza e ottimismo della volontà, si direbbe, in Bloch, come filosofo. E si nota, infatti, che anche gli altri “filosofi” fondamentali della Modernità tenderebbero all’ottimismo della volontà, anche se si tratta di un ottimismo molto sorvegliato e tenuto a distanza, non tanto dal pessimismo della ragione, quanto dal problematicismo della stessa, tendenzialmente scettico per forza di cose. Tra i nomi, Walter Benjamin e in genere tutta la Scuola di Francoforte, fino ad arrivare a Marcuse e alla sua filosofia da militanza utopistica, coltivata come ingrediente vivificante della vita quotidiana stessa: anzi pervasivo della vita stessa. A effetto ’68, infatti.
Ma anche i Sartre, i Camus, i Foucault…. Sono, in realtà, filosofi di tale risma. Dopo aver praticato ogni versante del nichilismo, le loro argomentazioni si prospettano come soluzioni se non ottimistiche, certamente non interamente pessimistiche: non interamente nichiliste. Il fatto è che tutti costoro, essendo “filosofi” tendenzialmente dialettici (anche quando vorrebbero non esserlo: tutti all’Adorno, più o meno, in proposito), cioè individuatori di discorsi e di situazioni trasformative, sono, sotto traccia, degli utopisti, per i quali l’utopismo, se non altro, è concepito come “un ricorso a un metodo”.
Resta questo dato di fatto, in qualche modo sorprendente, che mentre gli autori prevalentemente “filosofi”, anche se sono mossi dallo scetticismo dell’intelligenza, inclinano all’ottimismo della volontà; gli autori prevalentemente poeti, sono pessimisti nell’intelligenza e pessimisti anche nella volontà. La questione meriterebbe di essere indagata più approfonditamente. Una spiegazione d’ordine “funzionale”, o, se vogliamo anche “strutturale”, in quanto riguardante una questione di linguaggio, può essere indicata nel fatto che, proprio “strutturalmente”, la forma del discorso, specifica degli autori che sono “più poeti” (situazionisti irriducibili, situati appunto interamente nell’hinc et nunc del Dasein della loro esistenzialità nuda e cruda), è chiusa nella dimensione della pura sincronicità. Mentre la forma del discorso, invece, degli autori che sono “più filosofi” (più dialettici: più politici e più storicisti) sono di conseguenza portati dalla dialetticità stessa alla dimensione della diacronicità: la filosofia dell’attesa di ciò che potendo essere sarà. Vale a dire la via dell’utopia.
5. Sì, certo, il caso (anche letterario) di King Camp Gillette, nella sua apparente “rudimentalità” sembra essere molto lontano da tutto ciò, invece no. Intanto a conferma che il suo libro, che di per sé non sarebbe letterario, si deve dire che lo è comunque, per la sua parte, giacché ogni trattazione a impostazione utopica porta con sé una visionarietà d’ordine letterario (come si è già detto): e come tale, come per tutte le costruzioni utopiche, viene a costituire una specie di genere letterario a sé, che non sarebbe fuori posto classificare come genere utopico.
Sarebbe un genere misto, perché pone un duplice criterio di lettura e di valutazione. Da una parte il “libro utopico” (chiamiamolo pure così) richiede di essere visto e considerato come testo portatore di una teorizzazione politica e letto pertanto come tale; giacché sarebbe comunque un elaborato, di cui diventa indispensabile darne verifica sotto molteplici aspetti: politico, sociologico, economico, giuridico, tecnico, eccetera. E ciò indipendentemente dal fatto che la sua utopia sia valutabile dal punto di vista della possibilità o no a essere complementare di altre teorie politiche, non utopiche.
D’altra parte, è altrettanto indubbio che un testo utopico si presenti per il suo impianto da costruzione letteraria, nella sua parte che si presenta come “scrittura”, lo è anche come impianto da romanzo d’invenzione (l’utopia è l’escogitazione di un’invenzione che si metta al centro di tutto, come succede per qualunque altra elaborazione da invenzione). Dal punto di vista di un lettore, letterario ovviamente, un testo utopico è a tutti gli effetti portatore di un’invenzione trattata come una narrazione da romanzo, infatti.
E tanto più perché qualunque testo, di questo tipo, non può non essere marcato da un’espressività che costituisce fattore di un’espressività, se non letteraria in senso puro, paraletteraria senz’altro. Il che è il quanto basta per stabilire che è comunque di letteratura che si tratta. Prese in esame, in tal senso, si deve dire che tutte le costruzioni utopiche hanno in sé questa componente formale, che può essere considerata “indipendente” dall’argomentazione specifica del contenuto che ne costituisce la tesi o la teoria, che dir si voglia. Se è così che stanno le cose, allora ci si deve chiedere, se quest’aspetto letterario sia riscontrabile, e a quale livello, anche nel “trattato di un’utopia”, intitolato Il turbine umano di King Camp Gillette.
Beh, la risposta, anche sull’immediato, dopo ciò che si è detto finora, è subito pronta: nel senso che sì. Il titolo stesso del libro vale come indicazione di un contenuto più drammaturgico piuttosto che da argomentazione teorica. Peraltro, poi, tutto il libro, sia pur non tenendo conto di una certa rudimentalità, è percorso da una prosa indubbiamente coinvolgente e incalzante: rivelatrice, in questo, di una forza da convinzione autentica dell’autore su ciò che dice, anche per come lo dice. C’è, indubbiamente, il filone di un pathos interno, che poi è comune in ogni “testimonianza” orientata verso il superamento, sempre drammatico, da una condizione umana coartata (l’umanità investita dal turbine evidentemente anti-umano) a una condizione sociale per lo meno più umanizzata.
Certo, Gillette, non è un grandissimo del genere (non è un pensatore estremo): non è estremistico come può esserlo facilmente ogni utopista, che di per sé è portato a esserlo, perché è il genere stesso che lo richiede. Il suo essere completamente homo faber più che homo philosophus lo porta alla moderazione, sia nella progettazione proposta e sia nella passione con cui la sostiene; eppure il “demone inquieto” che accompagna sempre ogni prospettiva verso il ciò che ancora non è, ma che dovrebbe essere, proprio di ogni utopismo, lo si avverte anche in Gillette.
E non poteva non essere, giacché ogni utopismo è pur sempre un faustismo: un aver a che fare con una sfida temeraria, che ha in sé un che di demonico. Consiste in ciò lo specifico poetico del genere utopico, nel suo tentativo di far diventare possibile ciò che è creduto impossibile e di far diventare verosimile ciò che è definito inverosimile.
Certo, un testo di genere utopico può non essere del tutto scientifico, ma parascientifico certamente lo è. Può non essere del tutto politico, ma parapolitico certamente lo è. E può non essere del tutto letterario, ma paraletterario lo è: e guarda caso ha un suo “contenuto” che entra in pieno nel letterario “pieno”. E questo contenuto, presente in tutti gli autori d’utopia, è dato dalla presenza faustiana del demonico: un dato questo che conferisce a ogni costruzione mentale di questo tipo un che di appartenenza al pensiero, che certamente non è propriamente filosofico, ma teosofico sì. Eccome. Spirito dell’utopia e spirito della teosofia si corrispondono, nei testi che trattano sia dell’una e sia dell’altra. Oltre che con la teologia vera e propria.
Il demonico, appunto, che inaspettatamente in un autore sobrio come Gillette, spunta come rivelazione di una vena poetica che lo porta a comporre una “ballata” che ha per titolo Il lamento di Satana. Tema di per sé inaspettato per un argomentatore tutto prosastico, per come si presenta nei suoi testi social-politici, il nostro Gillette, così com’è inaspettato di doverlo leggere anche come poeta. Ma è in questo modo, quello poetico, che Gillette si sente di dover dire della risonanza immaginaria, simbolistica ed emotiva che la sua stessa concezione concreta genera in lui come emozione vissuta, anche in senso etico.
E’ evidente, intanto, che il ricorso al “personaggio” Satana, oltre a costituire ricorso di per sé alla allegorizzazione che è la “figurazione” necessaria cui la letteratura ricorre per essere letteratura (e con ciò, nel caso di Gillette, abbiamo una conferma in più della visionarietà utopistica come prossima alla visionarietà letteraria), resta da decifrare l’opzione indubbiamente religiosa, che l’autore suscita in se stesso con l’evidente passionalità che l’accompagna. Si tratta di un vero sentire da “credente”, che qui si fa esorcizzante l’impersonificazione del Male rappresentato da Satana, che “biblicamente” sta all’origine di ogni male.
E allora qui, in lettura ammirata, per la sua sincerità di convinzione, del poemetto, non si può non associarvi l’eco di un sentire già sentito in altri testi gloriosi della letteratura anglosassone (e della mentalità della tradizione religiosa anglosassone). Vanni De Simone, che è un conoscitore di Milton, potrebbe darcene conferma. E vi si potrebbe aggiungere Coleridge…
Insomma il tono letterario di quella tradizione (e del faustismo in genere) c’è, e il trono profetistico anche. Possono bastare per convincersene queste due strofe (tradotte benissimo dall’anglista De Simone, anche da poeta in proprio):
“Niuno al mondo può legger del destino / gli accadimenti, se non dietro le sbarre / della Ragion, ove il passato appare / come linea nell’ombra: un progredir, / della mente umana da buio a luce / lungo i cui raggi fluire. E giunti / ne’ pressi di fonte luminosa / da cui essa tutto il restante inonda.”
King Camp Gillette, Il Turbine Umano, Traduzione e cura di Vanni De Simone, Elemento 115, (pp. 305).